Un mondo di oggetti by Marco Meneguzzo
Un mondo di oggetti
Marco Meneguzzo
L’arte non è mai distruttiva. Potete cancellare con vernice bianca una miriade di segni che avete posto sulla tela, ed essi non scompariranno, ma vivranno al di sotto di quella superficie, e saranno in qualche modo sulla superficie… oppure potete ridurre un oggetto a un ammasso informe, dentro una pressa idraulica, ed esso acquisterà una nuova vita, rivelerà ciò che il suo essere oggetto funzionale nascondeva, la sua vita segreta… e non parliamo poi di ruote di bicicletta…
Tutto questo per dire che anche l’arte, come la sapienza di Dio, conosce e riconosce non solo il numero dei capelli che abbiamo in testa, ma soprattutto ogni segno, ogni gesto che venga usato con intenzionalità nella costruzione di un’opera: nulla va perduto, tutto è scritto. In questo senso Philip Tsiaras non ha paura di accumulare segni nelle sue opere, di sovrapporre oggetti nelle sue sculture, di esibire il corpo nelle sue fotografie: nulla va perduto, tutto è scritto. Questa assoluta convinzione lo porta a “riempire” lo spazio, ad allontanare quell’ vacui che può venire dalla pratica minimalista della contemplazione (anche nei suoi White Paintings che, come afferma nell’intervista riportata più oltre, sono una sorta di purificazione bianca, il grado zero della sua pittura, si ritrovano – emergenti dal bianco – furiosi e ossessivi accenni di figurazione), a stratificare cumuli di informazioni visive, senza la preoccupazione, tipica invece di chi si occupa di informazione di massa, di un rumore di fondo eccessivo, soverchiante.
L’arte può anche essere il contrario dell’informazione: può, cioè, aspettare a darsi, rivelarsi attraverso la forma metaforica dell’arabesco e non attraverso quella informativa della freccia, del vettore che va ineluttabilmente da un punto a un altro nel più breve spazio e tempo possibile: la Biblioteca di Babele, immagine borgesiana della letteratura e dell’arte, è tanto sconfinata da annullare il concetto di tempo. Quindi, per il linguaggio dell’arte, non c’è fretta. A questa, però, si sostituisce spesso l’ansia di dire, di dire senza tralasciare nulla, senza nulla dimenticare, pena lo scadimento dell’arte a informazione. Tsiaras appartiene a questo tipo di artisti.
Nel suo studio di New York – la caverna di Vulcano/Efesto sulla punta estrema di Manhattan -, mi parlava di “compressione”, a proposito delle sue opere. È una parola-chiave che mi ritorna continuamente alla mente, anche per le sue implicazioni fisiche, quasi meccaniche. Solo da poco il termine “compressione” è entrato nell’uso informatico, come una sorta di eliminazione di spazi privi di informazioni, ma è ancora la sua evocazione meccanica a tenere il campo, con l’idea di una tensione potenzialmente esplosiva, data appunto dalla compressione innaturale di elementi tra loro interagenti. Ebbene, non è lontana da questa fisicità l’azione artistica di Tsiaras, che comprime sulla tela – ma anche nelle sue opere tridimensionali, come vedremo – innumerevoli “quantità” di segni, di immagini, di relazioni, nessuna delle quali va perduta, ma anzi contribuisce ad aumentare la complessità visiva e concettuale dell’opera. Si potrebbe anche parlare, a questo proposito, di stratificazione, e non si avrebbe torto: tuttavia, quest’ultimo termine appare meno dinamico, e un po’ troppo archeologico. Se poi si pensa all’origine grecomacedone di Tsiaras, si rischierebbe di imboccare una via interpretativa eccessivamente centrata sulla presenza di radici culturali importanti, ma anche ingombranti, presenti ma ormai filtrate dall’onnivoro immaginario americano.
Così, quasi travolti da una valanga di segni – ma non è questo il senso odierno della civiltà dell’immagine? -, cerchiamo anche nell’opera di Tsiaras alcuni punti fermi, dei nuclei interpretativi che riconducano il magma a una ragione, qualunque essa sia: ma l’arte è anche una pratica pericolosa, che ti nega l’appiglio che credi di aver visto, e ti fa riprecipitare sul fondo, beffandosi di te e dei miraggi che avevi preso per realtà. Credo che uno di questi miraggi sia proprio la pretesa della classicità, che in genere si attribuisce a chiunque venga dal Mediterraneo (se poi si è anche greci, il colpo è doppio e il sillogismo Grecia/tradizione/classi- cità è dato quasi per scontato): invece, Tsiaras è un artista americano, che sa guardare a distanza le proprie radici e soprattutto che vive nel flusso di immagini e di oggetti che un tempo si sarebbe chiamato “pop”, e che ora non ha neppur bisogno di essere identificato, essendosi quasi sovrapposto all’idea generale di realtà.
Soltanto gli inizi del lavoro di Tsiaras sembrano indicare una scelta formale improntata alla riduzione, quando nelle sue fotografìe d’esordio 1975-78 – gioca su polarità binarie e contrapposte, come il movimento di un’auto ridotta a pure linee di velocità e l’immobilità quasi indifferente del paesaggio entro cui questa si muove, oppure, ancora, agisce tra la definizione massima del corpo umano e una sua parziale dissoluzione dovuta al movimento. Ecco, questa idea del “corpo” delle cose, e sopra ogni cosa del corpo umano, visto anche con un pizzico di narcisismo giovanile, potrebbe essere un residuo ideale e personale di quella classicità di cui si parlava poc’anzi, se non si dissolvesse rapidamente entro un contesto ambientale che ne frantuma ogni idea di unicità e, quindi, di bellezza non contaminata dal paesaggio. In quelle fotografìe, in tutte le fotografìe che Tsiaras ha scattato per più di un decennio pare svolgersi una sorta di viaggio iniziatico, in cui il rapporto psicologico tra il sé e il mondo è assai più evidente che nei quadri dipinti contemporaneamente, o nelle sculture immediatamente successive. Si tratta quasi di un diario, e non solo perché viene collocato sotto l’intrigante titolo di Family Album (ché, anzi, proprio questo titolo indica già un distacco, una distanza venata di tenerezza, ma anche di ironia), ma perché è la testimonianza diretta di un incontro tra il soggetto e gli oggetti, risoltosi tutto a vantaggio di questi ultimi. Il corpo atletico si riduce ad essere un corpo in mutande entro una stanza stracolma di souvenir, di soprammobili, di gadget, che ribadiscono il concetto di una memoria storica ormai irrimediabilmente distorta dai mass media: la famiglia, l’artista, la moquette, il Sacro Cuore di Gesù, le vedute di Atene in 3-D, il David di Michelangelo in polvere di marmo e plastica, alto un metro, è questa la memoria, dove si trova anche una buona dose di felicità, una volta accettato lo scivolamento, il décalage verso una cultura di massa. Solo in certe foto scattate nel deserto, tra Stati Uniti e Messico, si ritrova il concetto di corpo nel suo rapporto primario con la natura, ma ciò avviene per la forzata assenza in quella civiltà degli oggetti di consumo, dovuta appunto alla mancanza di consumatori (il deserto, si sa, non è luogo molto affollato…).
Tuttavia, ciò che premeva in questa breve digressione nelle fotografie di Tsiaras – che pure l’hanno reso noto anche come fotografo -, è notare come in queste la persona “privata” dell’artista, il suo carattere, siano più presenti, come se il linguaggio della fotografia fosse maggiormente aderente all’immediatezza dell’essere. Non a caso prima parlavamo di una specie di diario… e se la fotografia è diario, la pittura di Tsiaras vuole, al contrario, attingere a una dimensione epica.
La pittura, cioè, è una dimensione espressiva che nasconde il soggetto agente e privilegia il linguaggio, che vela il sé e svela il mondo. In questo senso vanno considerati i cicli pittorici di Tsiaras, che rispondono in maniera che vuole essere epica alle sollecitazioni del mondo. Anche e soprattutto nella pittura, per lui è valido il concetto di “compressione”, che trova in questo medium espressivo – e anche nei lavori in ceramica – i modi più felici e disinvolti (la disinvoltura del fare è vicina alla leggerezza, a quella virtù così postmoderna, e così apparentemente distante dalle stratificazioni successive della pittura che Tsiaras mette in campo: difatto, leggerezza e disinvoltura possono benissimo convivere con un’idea di pittura stratificata, soprattutto se questa viene da un flusso continuo e facile di sollecitazioni).
È il caso, evidentissimo, delle Topologies, ciclo iniziato nel 1990. Topologia, per Tsiaras, non è da intendersi in senso strettamente matematico – sembra più un titolo da pittore gestaltico, che simbolico figurativo! -, ma come “luogo” di possibili accadimenti visivi e concettuali: se la topologia è lo studio delle proprietà delle forme che non variano neppure se sottoposte a deformazioni estreme, e che quindi stabiliscono relazioni tra figure anche diversissime tra loro, una sorta di “topologia” pittorica può ben essere il luogo dove le immagini stabiliscono relazioni pur essendo differenti e dove si scoprono somiglianze altrimenti invisibili. Così, un aeroplano – la prima forma topologica di Tsiaras – non è altro che una croce in diagonale (“on tilt”, dice l’intervista) e, ai nessi spaziali tra le due forme, si sovrappongono anche nessi concettuali impensabili senza l’evidenza visiva e visibile della similitudine delle due figure. Se poi, com’è accaduto tra il 1990 e il 1991, l’immagine dell’aeroplano ha saturato per un mese tutti i mass media per via della guerra del Golfo, le cui uniche immagini erano quelle di decolli e di atterraggi di aerei, a una stessa forma – l’aeroplano, appunto – si attribuiscono significati formali, simbolici e anche storico-sociali, in un susseguirsi di piani di lettura che riconducono comunque all’unità iniziale della forma. È la topologia dell’arte.
Tuttavia, alla forma moderna dell’aeroplano – eccitata sulla tela da Tsiaras con una singolare preveggenza di qualche mese sui reportage dal Kuwait -, l’artista può tranquillamente affiancare quella antichissima del vaso – altro topos costantemente presente nel suo lavoro -, o quella tradizionale della testa, o ancora quella, già fortemente presente in molte fotografie, del cavallo: sono questi i “luoghi” e le “figure” simboliche che occupano quasi tutto l’immaginario pittorico di Tsiaras. Egli, cioè, utilizza una sorta di repertorio di forme, che giustamente sono state definite archetipe, per esprimere una varietà di relazioni, per indagare emotivamente il mondo: esse sono formalmente semplici e numerica- mente poco numerose, come sono di solito gli archetipi collettivi, ma èr dalle varianti formali del loro trattamento pittorico, dalla vicinanza di segni e di significati diversi che scaturisce la molteplicità e la complessita ideilo scenario in cui ci troviamo a vivere e a dire. Poi, naturalmente, la fantasia si eccita, a ragione, nella scoperta di significati archetipici nelle forme archetipe: così, vaso e testa potrebbero essere il femminile, aeroplano e cavallo il maschile, in un gioco a ritroso nell’oscurità del sentire e del vivere.
Tutto ciò è vero e necessario, ma non sufficiente per l’opera d’arte: il linguaggio della pittura, come tutti i linguaggi, è più un “modo” per dire che un “cosa” dire. Allora maschile e femminile e forme archetipe devono anch’esse sottostare alle leggi del linguaggio, che ogni artista tenta di elaborare secondo parametri che siano a un tempo personali e universali. Tsiaras ha scelto il modo della “compressione”, di cui si parlava prima, ha scelto, cioè, di riempire lo spazio e le forme con infinite informazioni secondarie, con deviazioni linguistiche che non sviino dal soggetto primo, ma che ne modifichino parzialmente la percezione, quasi fosse un’infinita, ricorrente decorazione. È questo il significato e il modo delle sue successive stesure, all’interno delle Topologies, stesure pittoriche spesso liquide, in cui compare anche una specie di scrittura invisibile, variante coltissima di certi graffiti metropolitani, o anche divertita citazione dall’automatismo scritturale surrealistico-informale, o ancora – penso che questo costituisca l’impulso primo della sua “scrittura” – disinvoltura del gesto, piacere dell’iterazione, puro gesto pittorico, volto a indicare la gioia e la voluttà del dipingere. Per fare un paragone con un’altra disciplina, ogni “topologia” di Tsiaras appare come una composizione musicale di “variazioni su un tema”, dove però, data la natura sincronica e non diacronica del linguaggio dell’arte, tema e variazioni sono dati nello stesso momento, sono offerti allo sguardo simultaneamente.
Maggiore analiticità – per quanta ne possa immettere in una sua opera Tsiaras, che analitico non è e non vuol essere – si ritrova in un altro suo ciclo di lavori, quello dei Sandwiches, che all’interno di tutta la sua produzione assumono quasi il ruolo di dichiarazioni di poetica, di manifesti teorici e oggettuali a un tempo. Un parallelepipedo grondante pittura, formato da un quadro sopra l’altro, ognuno dipinto, ma di cui è visibile soltanto l’ultimo, è come l’oggettualizzazione del processo pittorico: il quadro è il risultato di infiniti quadri, l’immagine è il risultato di infinite immagini, e quel che Tsiaras pare dirci nel suo pragmatismo iperamericano è che tutto questo non è solo pensiero, concetto, idea, ma piuttosto oggetto, materia, azione. Per questo la tangibilità dei Sand- wiches, di questi “quadri di quadri” costituisce la più forte concettualizzazione di Tsiaras: fare, produrre, comprimere, esaltare, riempire, ammucchiare, sovrapporre sono il mestiere dell’artista, secondo lui, e quest’ansia non può non esprimersi che attraverso la visibilità tattile della materia. A tal punto si vede questo nei Sandwiches, che anche il soggetto passa in secondo piano. Infatti ci sono Sandwiches figurativi e altri astratti, ma poco importa, perché questo, nel nostro caso, è un falso problema: la questione è invece tutta nel rapporto dell’artista col proprio strumento, che si trasforma in un’ossessione, per quanto felice. Dopotutto, il “capolavoro sconosciuto” di Balzac è una tela tanto dipinta e ridipinta da lasciar intravedere soltanto un piedino in mezzo a un magma di colori inestricabili…
Il senso di horror vacui, unito alla coscienza dello straripare della civiltà dell’oggetto, accompagna sempre l’opera di Tsiaras, anche nelle più recenti espressioni plastiche, le ceramiche e le fusioni. Del resto, è sintomatico l’accenno che fa – nell’intervista con Michael Komanecky – alla sorpresa che prova nello scoprire un magazzino con migliaia e migliaia di forme, destinate a un uso corrente, alla fabbricazione di soprammobili dozzinali, e che costituisce lo stimolo iniziale per questo ennesimo ciclo produttivo: Tsiaras è sempre più sedotto dagli oggetti, e dal loro cumulo che crea accostamenti inusitati e strani.
A guardare la storia dell’arte, come ha fatto Donald Kuspit nel suo ultimo saggio su Tsiaras – Private Myths, del 1993 -, questa è la caratteristica del surrealismo, che tende a creare la meraviglia attraverso il cortocircuito provocato dalla vicinanza di oggetti disparati; tuttavia, se la descrizione sommaria e scritta di questi oggetti si presterebbe a una loro collocazione in ambito surrealista, mi pare che ormai il problema dell’oggetto in arte non obbedisca più ai canoni dell’eccezionaiità della sua presenza, quanto piuttosto a parametri di assoluta quotidianità: la Pop Art ha cancellato il surrealismo, e forse ha anche ridimensionato Duchamp. In ogni caso, l’atteggiamento di Tsiaras verso l’oggetto, come di quasi tutti gli artisti “oggettuali” della sua generazione, specialmente americani, assomiglia maggiormente al desiderio infantile che all’intel- lettualismo onirico di storica memoria. Che poi, anche nelle sue scultu- re/oggetto, emergano ancora quegli archetipi esistenziali di cui si è parlato, è faccenda connaturata alla fascinazione sempre presente e sempre crescente dell’oggetto/feticcio, per il solo fatto della sua messa in scena, della sua ostensione. In questo senso, si ritrova il maschile e il femminile – una pistola infilata in un vaso panciuto pieno di buchi, ad esempio -, ma più ancora c’è la folle felicità di possedere tutte le forme, tutti gli oggetti possibili: ecco la Biblioteca di Babele dell’arte.
Le sue sculture in ceramica sono barocche, plateresche, ma anche da ipermercato di periferia: una Chevrolet Corvette in ceramica invetriata, incrostata di smalti come una sella messicana, occlude l’apertura del vaso; oppure, un vaso contiene un altro vaso che a sua volta contiene un vaso più piccolo; o, ancora, scarpe femminili dal tacco a spillo costituiscono le anse di un altro grande vaso… così, senza disturbare Georg Sim- mel e il suo famoso saggio su L’ansa del vaso, pubblicato nel 1911, dove tenta di stabilire il discrimine tra la funzionalità dell’oggetto e la sua valenza estetica, trovando questo confine, appunto, nell’ansa del vaso che è al contempo elemento funzionale e decorativo, i vasi/sculture di Tsia- ras risultano tutti afunzionali, impossibili, eppure così fortemente simbolici – il pesce, la scarpa, l’automobile, la pistola, il vaso stesso – da parlarci del feticismo dell’oggetto, nella sua rutilante e sfacciata inutilità. Sono sculture ma sono anche vasi (forse l’autore avrebbe preferito dicessi il contrario, ma sono convinto delle mie ragioni): cioè, se non conservassero la memoria del loro valore d’uso, della loro funzionalità, non comunicherebbero con tanta evidenza l’impossibilità di questo uso, che l’artista ha introdotto con le sue accumulazioni o “compressioni” di oggetti. Il feticcio è una metafora, ma anche una memoria.
Oggi Tsiaras si cimenta con fusioni in bronzo, in alluminio, in altri metalli. Non ci stupisce questa pratica eclettica – tra l’altro, uno dei suoi amici/maestri è Lucas Samaras, anch’esso d’origine greca, ma soprattutto teorico di azioni estremamente eclettiche e disparate, per quanto assai diverse da quelle del ben più giovane Tsiaras -, sia per una questione epocale, che vede gli artisti non più costretti entro i rigidi canoni dell’avanguardia, sia per quella sua personalissima disinvoltura nell’usa- re le cose, gli strumenti, persino i linguaggi. Un’enorme molla è sovrastata da un fragilissimo vaso, una pistola dalla canna spropositatamente lunga è posata su sostegni da albero motore, una base degna di Archi- penko sorregge ancora un vaso, ma anche un autentico pezzo di macchinario, senza alcun intervento da parte dell’artista, se non la sua nominazione come opera – sono solo alcune di queste nuove sculture e, ne siamo sicuri, sono solo un’altra tappa nel forsennato viaggio di appropriazione del mondo da parte dell’artista. Perché il mondo è pieno di oggetti, e Tsiaras li vuole tutti. E non solo idealmente.
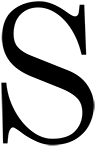

Read recent articles
IMMAGINI, IMMAGINI, IMMAGINI
Denis Curti L’ancien domaine
Denis Curti Der alte Besitz